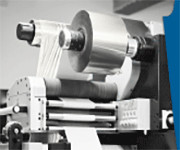Il 27 novembre 1957 è una data storica per la società italiana: apre a Milano il primo supermercato del Paese. Cinquecento metri quadri in cui si celebra quella che diventerà una rivoluzione commerciale e culturale destinata a cambiare, col portafoglio, la vita quotidiana. Fare la spesa, da quel momento, è facile e insieme divertente. L’abbondanza – purché industriale – diviene la norma. Coglie la portata del fenomeno Italo Calvino, che proprio in un supermarket fa vivere al suo antieroe, il manovale Marcovaldo, una delle sue avventure tragicomiche: lui e la famiglia manco sanno come si usa il carello… e gettano le merci dalla finestra. Il mondo sta cambiando, come testimoniano in quello stesso anno l’arrivo di Carosello, della Fiat 500 e della Comunità economica europea.
Ma nel 1957 succede qualche altra cosa, decisamente in controtendenza. Mario Soldati – scrittore, critico, sceneggiatore, regista – gira per l’allora unico canale televisivo RAI il documentario “Viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini”, che va in onda fra il dicembre ’57 e il febbraio ’58, dodici puntate (visibili su Rai Play) che dal Monviso giungono a Comacchio chiacchierando con casari e contadini, vignaioli e massaie, osti, pescatori, panettieri, ristoratori con tovaglia a quadretti e vino sfuso. La puntata sulla salama da sugo è commovente. Per Soldati, il problema non era riscoprire i cibi presunti veri, autentici, naturali: ma lasciarli dov’erano sempre stati, andarli a trovare a casa loro, nel loro contesto di produzione e di consumo.
Lo scontro fra civiltà non avrebbe potuto essere più aspro. E ancora ne paghiamo le conseguenze. Con la differenza che l’industria ha risucchiato tutto ciò che prima aveva soppresso: da tempo il genuino è divenuto un valore di brand, e sta nei supermercati sotto casa.
Ma l’ostinazione di Mario Soldati non si lascia ingannare e produce – tutto da rileggere – quel capolavoro assoluto che è Vino al Vino, il racconto di tre viaggi in giro per l’Italia nel ’68, ’70 e ’75 alla ricerca, questa volta, dei vini genuini. Occorre andare dal vino, ripete Soldati, e non attendere che esso arrivi a noi. Per cui, “la nobiltà del vino è proprio questa: che non è mai un oggetto staccato e astratto, che possa essere giudicato bevendo un bicchiere, o due o tre, di una bottiglia che viene da un luogo dove non siamo mai stati. Che cosa ci dice l’odorato, e il palato, quando sorseggiamo un vino prodotto in un luogo, in un paesaggio che non abbiamo mai visto, da una terra in cui non abbiamo mai affondato il piede, e da gente che non abbiamo mai guardato negli occhi, e alla quale non abbiamo mai stretto la mano? Poco, molto poco”.
Va inserita in questo ragionamento la nota affermazione dello scrittore torinese secondo la quale “le bottiglie di vino con etichetta sono quasi sempre cattive; le bottiglie senza etichetta e il vino sciolto quasi sempre buoni”. Non si tratta di una specie di anticipazione dello spirito no logo che oggi s’accoppia a certe velleità di ritorno alla terra: Soldati è lontano da tutto ciò. Quel che egli rifiuta nell’etichetta non è il marchio enologico ma l’attestazione, posticcia e ipocrita, di genuinità. Il vino, se è tale, è di per sé genuino: sentire l’esigenza di certificarlo significa presupporre che potrebbe non esserlo.
Problema tutto italiano, più culturale che economico: “Lo so che in Inghilterra alcuni ottimi whisky sono proprio quelli delle marche più note. E così in Francia certi Bordeaux o Bourgogne. Ma, in Francia e in Inghilterra, da secoli e non soltanto per vini e liquori, esiste un ponte tra società e individuo, una civiltà organizzata, una gerarchia del costume. La nostra civiltà non è inferiore, ma diversa. È una civiltà anarchica, scontrosa, ribelle. Da noi, l’uomo di valore, come il vino prelibato, schiva ogni pubblicità: vuole essere scoperto e conosciuto in solitudine, o nella religiosa compagnia di pochi amici”.
A 25 anni dalla scomparsa di Soldati e a 55 dalla pubblicazione di Vino al vino, cosa rimane oggi di questo autore? La risposta è abbastanza semplice: tutto. Non solo per il suo valore storico, per la sua capacità di anticipare i tempi, di subodorare quella catastrofe antropologica che Pier Paolo Pasolini nominerà tempo dopo. Dal punto di vista della cultura enogastronomica attuale, l’idea di un viaggio non turistico per le contrade del Belpaese (nome che un’azienda casearia userà per il suo prodotto di punta, invadendo massicciamente i supermercati) ci spoglia di troppe sovrastrutture gastromaniache che stanno incancrenendo, molto semplicemente, il gusto delle cose, dei cibi, della buona tavola. Il gusto, questo sconosciuto: andrebbe insegnato nelle scuole, nelle università, nelle accademie. Non la sua teoria, che pure serve, ma le sue pratiche, il suo senso, il suo valore civile e politico.
Soldati si accosta al gusto senza pregiudizi, senza paraocchi ma con curiosità sincera. È questa la genuinità di cui va in cerca nelle osterie fuori porta, nelle trattorie di campagna che si aprono su un cortile o sotto un pergolato, con tavoli di marmo, cespugli di ortensie e una proprietaria cuoca che ti accoglie dicendo “se s’accontenta”, servendo pane e olive, verdura di stagione, uova e formaggio. Questi posti senza nome, senza insegne e senza indicazioni in strada che permettano di scovarli sono, per Soldati, i migliori ristoranti possibili: “Quante volte ero passato davanti, e non ero salito su, proprio per il timore, per la quasi certezza, ‘di non trovare niente’. Proprio qui l’osteria c’era, ed era, se devo dare retta ai miei gusti, strettamente personali e individuali, la migliore del mondo: la più povera, la più semplice, la più pura, la più genuina”.
Ecco, l’“ingenuinità” profonda di questo sentimento tutt’altro che ideologico verso la gastronomia: è la ricerca del grado zero del cibo, di un gusto senza orpelli, senza aggiunte ma anche senza eliminazioni, che osa presentarsi per quel che è, grazie al lavoro di chi lo ha prodotto e alla socialità di chi lo consuma. In queste osterie, la chiacchiera è d’obbligo: si mangia parlando del più e del meno. Ma se ne trovano ancora?