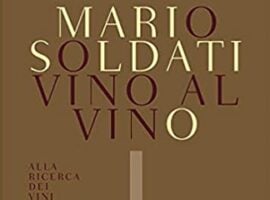di Titti Casiello
Eravamo quattro amici al bar. Poi siamo diventati otto. Poi dieci. Poi i dieci sono andati in altri bar con altri amici. Potrebbe partire così un nuovo linguaggio comunicativo.
Al primo che pronuncia un’astrusa parola, non contemplata neppure nelle note a piè di pagina della Treccani, l’ultimo (al bar) la dà per accertata dall’Accademia della Crusca. Non è un caso che oggi, ad esempio, è considerata già granitica la parola “smartworking”, anche se da dizionario inglese smart continua a significare solo intelligente e da noi, in Italia, smartworking è definito come un pseudoanglicismo. Eppure, fatto sta – perché sono i fatti che contano – che oggi smartworking è una parola d’uso comune. La domanda allora è: le nuove parole – codificate dal popolo – rappresentano un vortice virtuoso o un circolo vizioso? Parafrasando senza un preciso significato linguistico – così da non scontentare nessuno – potremo dire che le nuove parole sono il frutto di una circolarità vorticosa (o viziosa) dei tempi moderni.
Ma il punto è che se le nuove parole risultano producenti e produttive per capirci meglio, allora, ben venga il vortice o il circolo virtuoso. Il problema nasce, invece, quando non lo sono e generano solo confusione linguistica. E a quel punto che si fa? È il caso delle nuove parole di cui il mondo del vino si sta rifocillando. Sui siti internet di testate giornalistiche e sulle pagine social dei produttori spuntano nuove e stravaganti parole come: biosimbiotico, bio-life-style o biopotenziato. Ma da dove vengono? Da nessuna parte. Non hanno etimologia, non sono neppure pseudo qualcosa, non esistono insomma. Eppure sono parole, vocaboli che si stanno affollando nelle nostre voci e che potrebbero attecchire nella vita reale. Perché più sono fluide (a voler ironizzare sulle new word) e più risultano fascinose da utilizzare, assomigliando al libro delle risposte e lasciando all’uditore la più assoluta e libera interpretazione quanto al loro significato. Ma così facendo, però, ci stiamo muovendo su un crinale ripido e delicatissimo: perché se si esagera in un avvicendarsi di vocaboli del tutto arbitrari, si corre il rischio di non comunicare più una stessa lingua. E ciò vale ancor di più in un mondo, come quello del vino, dove già di per sé ogni parola codificata si presta a duttili interpretazioni, e queste nuove parole, non fanno altro che alimentare quelle già appurate difficoltà di comunicazione esistenti.
Se ci pensiamo, in fondo, le parole sono state forgiate nella nostra lingua, secondo etimologie storiche, per consentirci di trovare più o meno un minimo comune denominatore in quello che diciamo. Ma se continuiamo ad alterarle come ci capiremo più? Già quando si discute di degustazione di un vino, di uno stesso vino, e a volte sembra di vivere tra le pagine di Finnegans Wake di Joyce. Dove ognuno parla secondo il suo linguaggio e le sue sensazioni. Col risultato, molto spesso, di non comprendersi. Però se degustare significa (o dovrebbe significare) guardare al vino e parlare di lui secondo parametri comuni, più o meno condivisi, è pur vero che tutti quanti noi necessitiamo anche di un anelito di libertà quando lo descriviamo. In fondo è di vino che, appunto, si parla, e va da sé che tra un astringente e un sapido, possa trasalire anche un soddisfacente, appagante, profondo o sensibile. Il vino sarà anche degustazione, ma è anche esplicazione emotiva. Però quando si parla di tutto quello che c’è prima del vino, della vigna o delle scelte produttive, forse è giusto essere meno “sentimentalisti”, sposando i canoni linguistici che ci sono stati dati, evitando così di creare una nuova gigantesca torre di Babele. La linea è sottile, però bisogna non travalicarla se vogliamo continuare a parlarci.